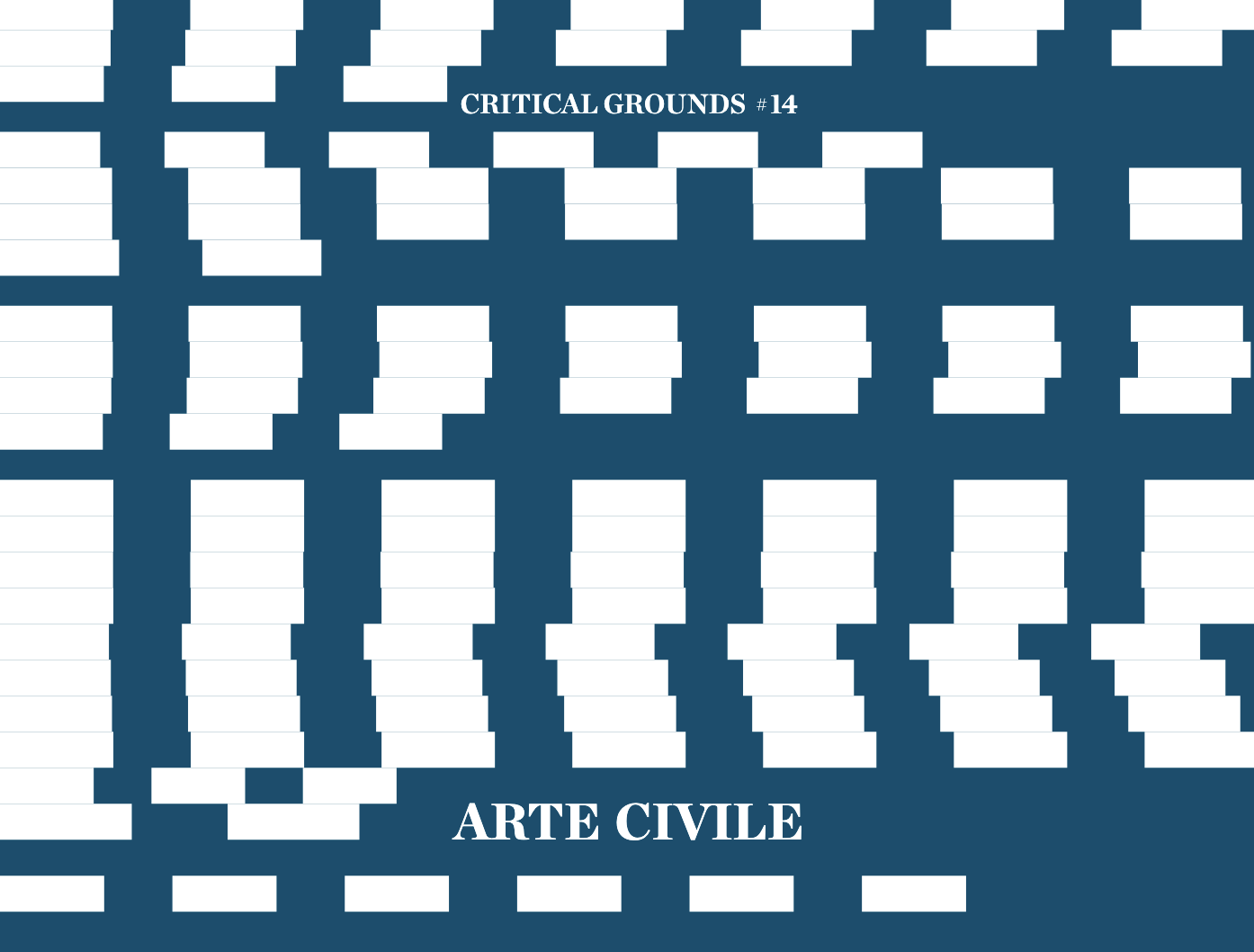Questa intervista è stata realizzata nell’autunno del 2023 e pubblicata nel volume Arte Civile a cura di Maria Giovanna Mancini e Maria Grazia Porcelli pubblicato da Edizioni Arshake – Reinventing Technology, Roma 2024
MGM
Partirei dalle parole, a cui riservi una grande importanza: a proposito delle tue performance e installazioni nello spazio pubblico, museale e urbano, non ami utilizzare il termine installazione né tantomeno riferirti a esperienze relazionali o partecipative. Potresti raccontarci come il cambiamento del linguaggio influenzi la tua pratica artistica?
VV
Alcuni anni fa, a Milano, nel raccontare del mio lavoro alla proprietaria della casa che volevo prendere in affitto ho usato, tra le altre, anche la parola installazione. E qualche mese dopo, la padrona di casa mi ha chiamata per chiedermi se potessi occuparmi di installare l’impianto di climatizzazione del suo ufficio. Al di là di questo aneddoto, ho imparato studiando legge e in parallelo studiando il pensiero femminista e le teorie della traduzione dell’importanza delle parole che usiamo, di quanto sia cruciale sceglierle con accuratezza e di come diano forma al nostro pensiero, alle persone e cose che nominiamo, alle nostre azioni. Penso che la pratica artistica si possa declinare anche nella creazione di un alfabeto, nel dare un nome al proprio agire. Per esempio nel mio lavoro preferisco parlare di “paesaggi performativi” al posto che di installazioni. La parola paesaggio include lo sguardo di chi lo abbraccia attraverso la vista, si ricollega alla tradizione dei paesaggi nella storia dell’arte, a questioni geografiche, architettoniche, ecologiche.
La parola paesaggio evoca e abita una frontiera tra discipline eterogenee. L’aggettivo performativo invece si riferisce ad una pratica che si sviluppa nel tempo, come una performance espansa, che trova avvio nella fase di ricerca e informa ogni linguaggio che uso come quello scultoreo, video, sonoro. E allo stesso tempo fa riferimento al rapporto con i pubblici che vengono invitati a essere naviganti, e semplici utenti, in questi paesaggi. L’altro esempio cui ti riferisci è “partecipazione” cerco di evitare questa parola perché trovo sia usurata dalla comunicazione dei partiti, della cosiddetta rigenerazione urbana e anche da parte di alcune pratiche artistiche. Inoltre non chiedo a nessuno di partecipare. Aspiro a creare spazi di dialogo con le singole persone, con le comunità temporanee, con chi collaboro, con il pubblico, con tutte coloro che scelgono di incontrarmi e incontrarsi nel farsi delle mie opere. Infine le parole sono il modo primo in cui disegno. L’ideazione è prima di tutto descrizione di ciò che immagino.
Scrivo una partitura che poi condivido con le persone che collaborano con me e con la committenza, con la curatela. Da questa partitura prende avvio il processo che porta alla creazione dei paesaggi sonori, scultorei, performativi o video.
.

(…..)
MGM
Hai proposto spesso performance delegate e pratiche collaborative più che partecipative. Il tuo modo di lavorare nei termini di una costante collaborazione accoglie una tendenza a lungo praticata dagli artisti che potremmo definire di autorialità debole. Forse è un termine improprio ma recupera un dibattito in auge negli anni ’80 in ambito estetologico e sottolinea la necessità di non rinunciare all’autorialità che, allo stesso tempo, è pensata in rapporto con gli altri soggetti coinvolti in termini non autoritari. Sono fuori strada?
VV
Non sei fuori strada, pur non conoscendo a fondo e non avendo come riferimento teorico “il pensiero debole” di Vattimo, mi sembra che la traiettoria che tracci possa inquadrare il mio lavoro. Ti rispondo con un’altra pensatrice, Rosi Braidotti, e con una frase che scrive nel suo famoso Soggetto Nomade (Donzelli, 1995, trad. it.)
«far parlare voci altre nei miei testi è quindi un modo per mettere in atto la non centralità dell’io rispetto al progetto di pensiero, e riconnetterlo invece ad un progetto collettivo».
Braidotti si riferisce all’uso della citazione nella scrittura, per estensione sin dagli inizi del mio lavoro questa frase è stata un riferimento per pensare ad una pratica che si nutre di collaborazioni, incontri, citazioni e diversi pubblici.
Provo a sintetizzare. All’origine del mio lavoro ci sono ricerche fatte sul campo frequentando anche per anni, persone e spazi legate ai temi che mi interessano come nel caso di Alzheimer Cafè, o come è successo con direttori d’orchestra, ghost writers, o hacker e scienziati del web. Questa ricerca, come scrivevo all’inizio della nostra conversazione, è performativa. Mi rapporto a questi contesti come artista e come intrusa. E uso questa parola nell’accezione di intruso che Nancy dà nel suo omonimo libro (che mi accompagna sin dagli inizi) parlando della sua esperienza di trapianto di un cuore, straniero che resta tale pur diventando parte del suo corpo. E questo essere accolto e restare straniero permette di abitare uno spazio ibrido che si colloca tra distanza e vicinanza e che permette di portare domande. Come quelle che pongo alle persone che incontro e con cui mi confronto in questi periodi di ricerca e che considero il primo pubblico del mio lavoro. Con loro parlo del loro lavoro, del mio, di storia dell’arte, di scienza, in un processo nutritivo di scambio e arricchimento reciproco. Questa fase di accumulo di conoscenza va poi incontro ad un processo di sottrazione, in cui cerco di arrivare a quello che per me è il nucleo del lavoro (es. i ricordi musicali, la cypherpunk mailing list) e a questo punto invito altre persone a collaborare. Che siano performer, danzatorə, sound designer, video maker, artigianə tuttə sono attivamente coinvoltə nel farsi del lavoro. E sono anche loro allo stesso tempo attorə e il secondo pubblico che il mio lavoro performativo incontra.
Mi interessa praticare una regia informata dai principi dell’unleading (cfr. https:/ www.yorku.ca/edu/ unleading/). E pur curando ogni dettaglio del processo e della sintesi finale, creo delle griglie in cui le altre soggettività coinvolte hanno spazio per improvvisare. Si attiva così un processo di intelligenza collettiva di cui “perdo” felicemente il controllo. Uso un’altra citazione, di Vidya Shah, che nel suo progetto educativo sull’unleading dice:
«Cosa può significare disfare e disimparare le pratiche e le idee che promuovono la gerarchia, l’individualismo, la conformità, il potere, il silenzio e la cultura della paura? UnLeading richiede l’impegno a sostenere verità multiple, a mettere in discussione i presupposti del senso comune, a vivere le indagini e a sedersi nelle ambiguità di idee complesse come la leadership, la scuola e la società. UnLeading ci chiede di impegnarci nella prassi della leadership, una continua interazione tra l’azione verso il cambiamento sistemico e la profonda riflessione interiore. In questo modo, si tratta di un processo in divenire, senza una destinazione predeterminata o un obiettivo finito».
Racconto così nel dettaglio questo processo perché mi interessa condividere un metodo, possibile codice sorgente per altrə che lo potranno migliorare e portare avanti, così come ho imparato spesso accade nella comunità scientifica. Così come il web delle origini ci suggerisce di fare, condividere la conoscenza il più possibile perché non è importante chi la porta avanti, ma che continui a nutrire altre.
.

MGM
La riflessione su alcuni temi emersi negli anni più recenti, in particolare quello sull’intelligenza artificiale, sullo spazio del web e dell’identità individuale in rete, oggi sembra essere centrale nella tua pratica. I temi su cui lavori, apparentemente così eterei, non ti hanno spinto a rinunciare alla materialità delle “costruzioni” (tu spesso li definisci paesaggi) che realizzi. Come risolvi, se è tua intenzione risolverla, questa apparente contraddizione?
VV
La mia risposta è già compresa nell’aggettivo che usi per definire questa contraddizione “apparente”. Non mi sembra necessaria una coincidenza tra materialità dell’opera e immaterialità dei temi che affronto. Anzi penso che questo spazio di contraddizione, questo movimento, possa essere prolifico. È una dualità presente anche nel ciclo di opere che citi e che dal 2015 dedico ai processi di digitalizzazione delle nostre vite e alle tecnologie del web, una ricerca che si alimenta sul campo e attraverso studi che mi hanno portata ad ottenere un Master of Science in Digital Currencies nel 2019.
Il lavoro che più incarna questa tua osservazione è Tails un paesaggio performativo,
composto da una scultura in cartapesta e suono diffuso su otto canali, che mette in
scena, in scala 1:2000, la lunghezza di tutti i cavi in fibra ottica che attraversano gli
oceani del pianeta. Tails nasce da un dato numerico e da una domanda. All’inizio del 2023 la stima dei cavi sottomarini che utilizzano la tecnologia a fibre ottiche è di circa 552 per una lunghezza complessiva di 1.4 milioni di chilometri. E se tutti i cavi che permettono le nostre connessioni raggiungessero la superficie e affiorassero in uno spazio chiuso, cosa vedremmo? Faremmo esperienza di una danza di cavi, una danza fra i cavi che permettono le nostre vite digitali. Il lavoro è stato prodotto tra la primavera e l’inizio dell’estate 2023 da Spazio Murat Bari in una mostra personale a cura di Silvia Franceschini. Abbiamo lavorato con il contesto in diverse declinazioni: con l’architettura dello spazio, la scultura infatti si ramifica orizzontalmente nella galleria trasformandola e dialoga con il mare che si affaccia a pochi metri di distanza. Con l’uso della cartapesta, per realizzare la struttura ho collaborato con un architetto e un artigiano che vengono dalla tradizione del Carnevale di Putignano (in provincia di Bari). Questo lavoro, come gran parte della mia pratica artistica, si nutre di movimenti contrapposti. Ho scelto la cartapesta, un materiale completamente analogico, sostenibile, fatto di carta, acqua e farina che ha la particolare proprietà di conservare la memoria del calco in cui si asciuga e di perderla se immersa nell’acqua. I tubi realizzati in questo materiale dalla memoria fragile, alludono all’infrastruttura sottomarina che permette le nostre connessioni immateriali e la creazione di memorie permanenti digitali. L’immagine di partenza del lavoro è stata realizzata attraverso una IA generativa, un modello text to image, e mette in scena allo stesso tempo l’andamento rizomatico del web e decentralizzato della blockchain. Tails, infine, prende il nome da un software che se installato sui nostri dispositivi consente di cancellare traccia, e quindi memoria, di qualsiasi attività compiuta ad ogni log-off. Ho scoperto dell’esistenza di questo software alcuni anni fa leggendo l’autobiografia di Snowden. In quel periodo le mie ricerche mi hanno portata a frequentare Bitcoin Meeting in Svizzera e attraverso le criptovalute mi sono avvicinata all’uso della criptografia, al diritto alla privacy online e di conseguenza alle questioni dell’identità digitale. Tema quest’ultimo cruciale per le nostre vite digitalizzate tutt’ora nude e generatrici di capitali di dati, proprietà di monopoli privati e di nazioni e di stati che costruiscono il nostro, solo apparentemente invisibile, “permanent record”.
A questi temi ho dedicato anche un’altro ciclo di lavori dal titolo Crypto Party,
un progetto sperimentale che si svolge on/off line al confine tra arte e pedagogia
sostenuto dal Museo Ma*Ga di Gallarate con la cura di Alessandro Castiglioni. Il
primo capitolo di questo ciclo si è svolto su uno dei primi metaversi open source nato durante la pandemia, Mozilla Hub, e ha coinvolto un liceo in un percorso nella storia del web che parte dalla polionimia dell’internet delle origini e giunge alla coincidenza problematica che c’è oggi tra identità fisica e digitale. Potrei scrivere ancora molto di questi temi. Tuttavia mi sembra di essermi dilungata a sufficienza.
Concludo la nostra conversazione con un riferimento alle ultime sperimentazioni cui questa ricerca sul digitale mi ha portata: quelle con le IA generative per la creazione di una serie di video dedicati a quell’oggetto relazionale che chiamiamo denaro (La Matematica del Segreto, 2023/ongoing). Anche il tema delle IA generative è legato alle questioni dell’identità digitale. Le IA si sono formate su tutto quanto abbiamo postato, scritto, pronunciato, pubblicato sul web da quando è nato. Immaginiamo il download di un mare magnum di dati possibile proprio per l’assenza di una identità digitale che ci tuteli dalle piattaforme che usiamo giornalmente. In questo senso trovo interessanti le ricerche di chi come Christopher Allen, architetto della Blockchain, impegnato nella difesa della privacy intesa come uno dei diritti umani fondamentali, sta lavorando per portare alla creazione della cosiddetta Self Sovereign Identity o identità digitale decentralizzata. Tornando ai modelli di text to text e text to image con cui mi sono confrontata, come già alcunə artiste hanno evidenziato, hanno assorbito da noi anche e i bias di genere, razza e specie, per citarne solo alcuni, che ancora affliggono i nostri modi di pensare.
Il training oggi continua involontariamente mentre ne facciamo uso. E su questa formazione continua indotta da utentə ci sono già discussioni in atto da parte di teoricə e scienziatə. ll MIT Technology Review ha pubblicato un articolo in cui racconta come le grandi aziende informatiche subappaltano la formazione delle IA a piattaforme come Mechanical Turk in cui lavorano dipendenti sottopagati per formare le IA. E questi dipendenti spesso, per velocizzare il loro lavoro, si affidano a chatbox come ChatGPT.
È ormai un dato acquisito che i modelli linguistici di grandi dimensioni presentino
informazioni false come fatti. E cosa succede se queste false informazioni vengono a loro volta utilizzate per addestrare altri modelli di IA che assorbono questi errori?
Sembra farsi strada la necessità di una nuova forma di pedagogia che abiti la soglia tra intelligenze viventi e cosiddette intelligenze artificiali.