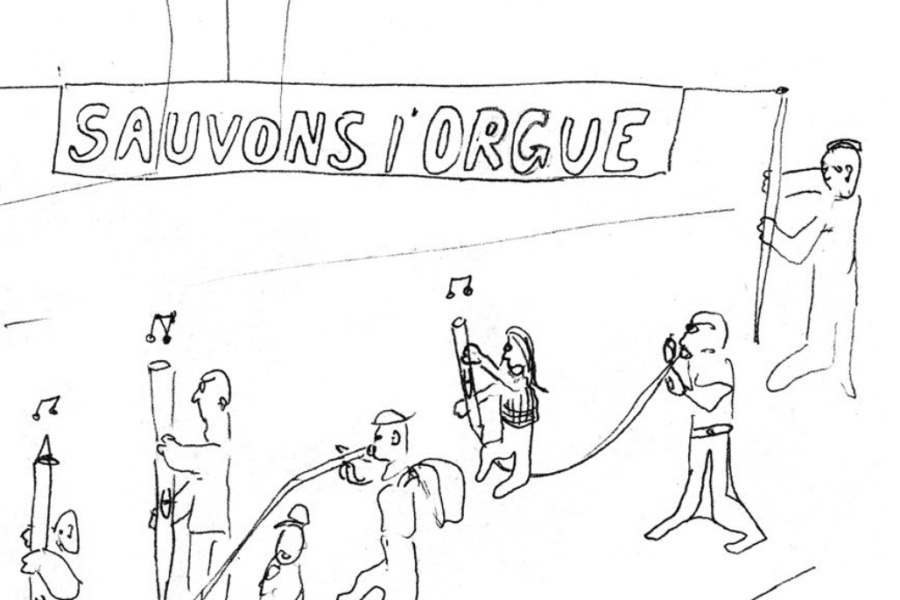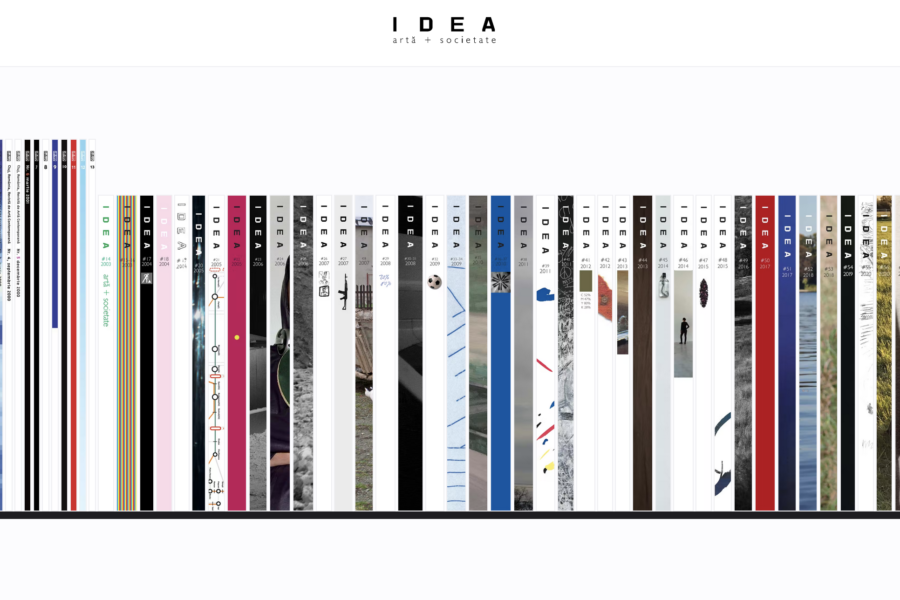Come si struttura e percepisce il tempo quando la durata di una esperienza è già dichiarata in partenza? Il tempo forse diventa attesa, esperienza dell’attesa. La fine acquista importanza, pur lasciando intatta o persino potenziata l’intensità dei momenti che compongono l’intero.
Domenica pomeriggio nella sala ricevimenti di Villa Maraini, la sede dell’Istituto Svizzero, abbiamo sperimentato in gruppo un tempo scandito dalla musica. Il programma annunciava la durata del concerto: trecento minuti circa, ma si sa la musica va interpretata e le pagine scritte da Feldmann sono state tradotte dai quattro archi in un nuovo tempo. Solo allo scadere della quinta ora ho preso coscienza del numero di pagine degli spartiti che ancora attendevano di essere lette e da quel momento il tempo è stato incerto, incertezza della durata, dell’attesa che si è estesa si è protratta per la successiva ora. Dalle quattro del pomeriggio alle nove di sera di domenica cinque maggio il Black Mountain String Quartet ha eseguito il Quatuor No 2 del 1983 di Morton Feldmann. Alla fine, al momento dell’ultima nota uno dei violini ha dichiarato qualcosa che ricordo imprecisamente così: “Ci siamo riusciti, siamo arrivati alla fine”. Lasciando in me l’impressione che anche per loro l’esperienza si sia legata all’attesa, alla fine.
Del resto il tempo come si può percepire se non in termini di distanze, durate, dilatazioni e corse ?
Cristiano Serino, primo violino, Mervit Nesnas, secondo violino, Riccardo Savinelli, viola e Alfredo Mola, violoncello. Una donna e tre uomini tra i trenta e i quarant’anni tesi in quest’atto dalle fattezze epiche: interpretare senza pausa alcuna le pagine di Feldmann. Il riferimento al college del North Carolina e ai compositori che lì operarono è dichiarato.
I quattro musicisti sono su di una pedana, quasi una croce da cui aggettanti sorgono le sedie in un unico movimento del legno dipinto di bianco. Il punto di vista offerto al pubblico che sosta in questa sala centrale e sceglie la prossimità con i musicisti, è piuttosto insolito. L’altezza della pedana, posta al centro della sala, fa si che chi è disposto sulle sedie o sui cuscini lungo le pareti per prima cosa abbia di fronte le gambe degli interpreti, i jeans, il vestito rosso, i piedi nudi (unico sollievo in questa giornata assolata di primavera). Mi chiedo quanto ne fossero consapevoli gli architetti che hanno curato l’allestimento. Il punto di vista è proprio su quella parte di corpo che è termometro dell’attesa e della fatica del suonare, dello sforzo necessario per raggiungere il traguardo. Se le braccia e il busto sono impegnati con gli strumenti, le gambe portano i segni dell’impegno e del trascorrere del tempo: dapprima tese e composte quasi rigide nel portamento da musicista classico pian piano si sciolgono, la postura si allentata, i piedi si spostano e cercano riposo.
All’obbligo imposto ai musicisti dalla partitura corrisponde la libertà di fruizione del concerto offerta al pubblico dai curatori del programma. Intorno alla sala centrale si affacciano altri ambienti allestiti per l’occasione per creare condizioni e mondi di ascolto differenti. Del resto la ricerca musicale e non contemporanea è spesso incentrata sulla creazione di condizioni nuove per l’ascolto e la visione, sul ruolo del pubblico che poi è la realtà.
Dopo aver trascorso le prime due ore sui cuscini prossimi ai performer concentrata sull’ascolto, dando priorità all’ udito, mi concedo il lusso di alzarmi e andare a scoprire la sala sulla destra. Non pensate che la musica immersa in queste possibilità di scelta possa diventare cornice. No, gli spazi di Villa Maraini sono reinventati densamente dalle note di Feldmann. Gli archi generano gli spazi e l’esperienza che viviamo, il resto: le suppellettili, i viveri, gli stucchi, i quadri alle pareti, la luce e persino gli altri astanti sono la cornice.
L’esperienza della musica, di questo tempo che prende forma tra le stanze luminosissime, è insieme soggettiva e comunitaria. Si parla molto poco o nulla eppure il pubblico compone una sorta di coreografia. Con i nostri movimenti negli spazi siamo parte di un corpo danzante eppure siamo persi nel singolo ascolto, nelle riflessioni introspettive. Di tanto in tanto capita di scambiare uno sguardo, un sorriso. Si spia il vicino, cosa legge? Lentamente si va formando una comunità temporanea che attende. Una coreografia della resistenza, che tuttavia per noi, il pubblico è resistenza comoda.
Raggiungo la sala a destra. Quindici lettini da mare sono disposti verso le finestre così da orientare lo sguardo verso il cielo e il giardino rigoglioso e dare le spalle alla stanza della musica. I lettini contaminano la sala ricevimenti della villa. Scelgo uno dei più prossimi alle finestre, sono spalancate, il sole colpisce me e la mia vicina, una donna in verde e grigio, molto bella: verde la camicia e la lunga gonna, grigia la capigliatura folta tenuta da uno chignon. Con lei condivido questa nuova forma di ascolto tutta protesa verso l’esterno della sala e l’interno dei pensieri. Lontana dai corpi dagli strumenti, mi concentro sull’osservazione dei suoni. I toni sono bassi o medi, il ritmo accelera di rado, la melodia si ripete come cercando una continua variazione al suo interno, la variazione è minima e segue uno schema, talvolta le corde sono pizzicate, il dialogo tra le quattro voci è serrato, sono due contro due, tre contro uno, oppure ognuno per sé.
La mia vicina cambia posizione e si siede, dà alle spalle alla finestra, indirizza la vista e l’udito verso la sala della musica.
Incoraggiata da una ragazza che, sdraiata su di un lettino, alle mie spalle legge, mi autorizzo a prendere il libro che ho in borsa: Tolstoj “La sonata a Kreutzer”. Mi distrarrò troppo?
Sono stata in giro per Roma questa mattina e ho casualmente con me la lettura di questi giorni, come sempre per alleviare le attese dettate dai mezzi di trasporto pubblici. Tuttavia una strana coincidenza mi porta a trovarmi tra le pagine in cui l’omicida racconta al suo vicino di treno, il narratore, del percorso che lo ha portato all’atto furioso: accoltellare la moglie. Narra di come sia stata proprio la musica, il Beethoven della Sonata a Kreutzer che i due, la moglie e l’altro, suonavano, a creare lo spazio del tradimento immaginato o forse reale e a scatenare la sua follia.
“E in generale fa paura la musica. Che cos’è mai? Non lo capisco. Cos’è la musica? Che cosa suscita? E perché suscita quello che suscita? Dicono che per effetto della musica l’anima si elevi: sciocchezze! Non è vero! L’effetto c’è, un effetto terribile, lo dico per esperienza personale, ma non eleva certo l’anima. Non eleva l’anima e neppure la deprime, ma semplicemente la irrita. Come spiegarvi? La musica mi costringe a dimenticarmi di me stesso, del mio reale stato d’animo, mi trasferisce in una situazione diversa, estranea; sotto l’effetto della musica mi sembra di sentire quello che in realtà non sento, di capire quello che non capisco, di potere quello che non posso. Me lo spiego pensando che la musica agisce come lo sbadiglio, come il riso: non ho sonno, ma sbadiglio quando vedo qualcuno sbadigliare; non c’è niente da ridere, ma rido sentendo altri che ridono. La musica mi trasferisce d’un tratto, subito all’istante nello stato d’animo in cui si trovava chi l’ha scritta. Mi fondo con la sua anima, e assieme a lui passo da uno stato all’altro, ma nello stesso tempo non ho idea del perché lo faccia.”
Le riflessioni del narratore sulle capacità della musica si mescolano con le mie sulle note che ascolto e il racconto di questa violenza mi riporta alla storia di Melania Rea uccisa a Civitella del Tronto cui ho dedicato un lavoro, ai temi che fuori da queste camere investono l’attualità, al progetto contro il femminicidio e alle riflessioni della presidente della camera sulla condizione femminile in Italia.
Guardare verso l’esterno mi sta portando lontano dai nostri musicisti, abbandono il lettino con la sensazione di essere negligente. Prendo una tazza di tè, torno nella sala centrale e questa volta mi accomodo su una sedia. Devo essere diligente. Mi concentro, studio il dialogo tra i musicisti. È il primo violino a dirigere. Sembra il più adulto. Sorride. Sorride più spesso degli altri e conduce con lo sguardo, con il respiro segna il tempo, gli attacchi, le pause, incita nei momenti di stanchezza, crea complicità sulla pedana. Lei è vestita di rosso e ha lineamenti persiani. L’altro di fronte ha i capelli ricci. Il violoncello non lo riesco a vedere, sono alle sue spalle.
L’insieme di queste note, delle ripetizioni, degli scarti minimi sembrano portatori di una potenza generatrice, una capacità di non finire mai, di riprendere pronta e fresca quasi fosse un nuovo inizio. Eppure, c’è un momento in cui pensi: forse ora vado, abbandono il campo. Poi cambi stanza, prendi un grappolo d’uva e ti ritrovi rapita lì ad ascoltare. Questa volta sono in una sorta di giardino d’inverno. L’ambiente è luminoso, speculare a quello dei lettini, le finestre ampie e alte, il giardino è a vista, il cielo brilla e le piante incorniciano e distanziano comode poltrone. Se Feldmann impone ai musicisti una fatica dai toni epici, agli ascoltatori qui oggi è offerta una sorta di prigione dorata.

La stanza attigua è una sala lettura. I libri sono a tema, suggeriscono percorsi e riflessioni sulla musica contemporanea. Scelgo una raccolta di saggi di Schoenberg Il pensiero musicale.
“In musica le ripetizioni di certe parti minime (motivi, figure, frasi) danno prima di tutto la possibilità di riconoscere queste piccole parti come legate da un’affinità.
Il ricordare si basa sul conoscere e conoscere di bel nuovo.”
Dedico questa pagina a Marco Angius e ai sette direttori d’orchestra con cui a settembre del 2011 abbiamo sperimentato un altro tempo di attesa, quello di un Ravel interpretato in loop per alcune ore in un cerchio.
Photo credit: Ilan Zarantonello – OKNO studio per Istituto Svizzero di Roma, SYNCOPE – Evento #3:”EXTENSION”, BLACK MOUNTAIN String Quartet in concerto, 4 maggio 2013.